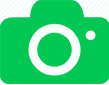Nel corso del tempo il synth, più di altri strumenti, si è evoluto passando dall’analogico al digitale per poi, in un certo senso, tornare al punto di partenza con una soluzione che potremmo definire ibrida.
Il sintetizzatore ha avuto un impatto non indifferente sul modo di fare musica, diciamo pure che si è trattato di un evento rivoluzionario, una innovazione che ha spalancato nuovi orizzonti ai musicisti più creativi che per primi hanno saputo incorporare questo strumento nelle loro composizioni e che oggi è diventato diffusissimo. È interessante notare poi l’evoluzione del sintetizzatore più venduto dagli albori, quando era parecchio ingombrante e analogico ad oggi, decisamente più compatto e digitale, persino virtuale.
A cosa serve
Ma in sostanza a cosa serve un sintetizzatore? Cosa fa? È uno strumento che appartiene alla categoria degli elettrofoni ed è in grado di generare dei segnali audio che possono esser sotto il controllo diretto di un musicista o di un sequencer. Il synth imita strumenti musicali reali ma può anche creare suoni ed effetti che magari neanche esistono in natura. Principalmente il sintetizzatore è comandato grazie a una tastiera, per intenderci una come quella del pianoforte. Ad ogni modo esistono anche synth che possono essere comandati mediante altri controller.
Come funziona
Ci sono una serie di componenti che danno il loro contributo alla creazione del suono, vedremo quali tra un attimo. Prima, però, vogliamo sottolineare che la tecnologia in fatto di synth è mutata non poco dagli anni ‘60 ad oggi, basti pensare che i primo modelli erano analogici, caratterizzati da un suono instabile, erano privi di memoria quindi non si potevano salvare i suono creati e richiamarli semplicemente premendo un pulsante.
La riproduzione degli strumenti, poi, non era il massimo in fatto di fedeltà fatta eccezione per i sintetizzatori davvero costosi usati in campo professionale. Oltretutto, almeno fino agli anni ‘70, questi apparecchi erano monofonici. Poi cosa accade? Successe che negli anni ‘80 si passò dall’analogico al digitale: la rivoluzione nella rivoluzione. Tra i vantaggi più evidenti con il passaggio c’è la possibilità di memorizzare i suoni creati, la polifonia e una fedeltà di riproduzione degli strumenti anche in modelli di sintetizzatori più economici.
Nel frattempo, però, cresce la nostalgia verso il suono analogico così nel nuovo decennio appaiono nuovi sintetizzatori. Negli anni ‘90, infatti, fanno la loro comparsa i virtual analog synth. In sostanza si tratta di strumenti capaci di emulare i circuiti dei vecchi synth analogici pur tuttavia restando digitali.
Le componenti chiave
Come promesso, vediamo alcune delle componenti chiave di un sintetizzatore e come si comportano. Cominciamo dall’oscillatore; la sua funzione è di scegliere l’onda sonora caratterizzante il suono. A disposizione ci sono cinque onde, ovvero, sine, triangle, noise, square e sawtooth. All’oscillatore vanno applicati dei parametri: il volume, che riguarda l’onda ma non il suono, l’octave che serve a scegliere l’ottava sulla quale suona l’oscillatore, con il parametro semi si sceglie la tonalità in semitoni e infine il detune.
Un’altra componente importante è il filtro o meglio, i filtri visto che ce n’è più di uno. Il lowpass, per esempio, taglia le frequenze che superano la soglia impostata tramite il cutoff. Lo highpass, invece, taglia le frequenze inferiori alla soglia precedentemente impostata. Per tagliare tutti i suoni esterni alla banda selezionata c’è il notch. Naturalmente anche il filtro ha dei parametri come il cut off che abbiamo citato un attimo fa e che indica le frequenze sulle quali lavorare.
Per enfatizzare le frequenze, si agisce sul parametro della risonanza.
Adesso parliamo dell’inviluppo. Cos’è o meglio, cosa fa? Determina una variazione di tensione nel tempo. Per fare ciò, si serve di alcuni parametri. L’attack, ad esempio, riguarda il tempo necessario per arrivare al massimo. Il decay, invece, indica l’ammontare di tempo necessario all’inviluppo per arrivare al livello di sustain precedentemente indicato. Il sustain, infine, agisce in modo tale che il decay si mantenga stabile in un dato tempo.